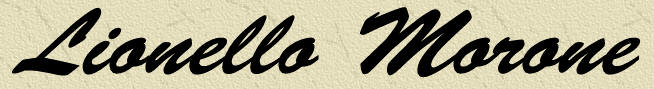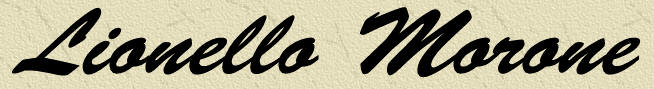|
Storia e
preistoria di un pittore
Che ci siano risultanze
allotropiche in non pochi quadri di Lionello Morone è fuori
discussione, così come è ammissibile che gli stessi titoli
globali, Fiori con paesaggi, Pleniluni,
Migrazioni intendano andare oltre la reperibile sostanza del
fatto figurale. Ma ci troviamo in un giro per niente vizioso fra
uno spogliarsi dalle maniere astratte, informali e da appigli
simbolisti e decorativi (certe tessere staccate di fiori fra
redoniani e klimtiani) per giungere a un paesaggio fisico, e
viceversa – ma di quanti pittori questo si può dire, da Gorky A
De Kooning, mettiamo, a Pignon, allo stesso De Stael: le
categorie della forma non contano in modo impegnato, esclusivo;
la scoperta di certi pittori d’oggi è la libertà anche in questo
senso ,giustamente è stato osservato che la materia tradizionale
pittorica va osservata come medium.
Dei fiori, sempre ricorrenti in
Morone, si può anche osservare che sono embrionali, puntuti,
duri; ma che egli intenda, per dirla con Cézanne, realizzare le
sue sensazioni alla presenza della natura è innegabile, e
giustifica così perfino in senso letterale i titoli delle sue
tele, così come gli elementi fedelmente morfologici nei profili
di astri, monti, valli no escludono la collusione informale,
raggiungendo talvolta una violenza cromatica, come in alcuna
Migrazioni, dell’intensità dei “Cobra”, timbrici, finanche
percussivi. A buon diritto A. Mistrangelo, dopo aver accennato
per alcune di queste opere a un simbolo magico di un nuovo
universo, accredita a quei colori un “senso di astrazione
contemplativa”.
L’interesse è la molteplice, niente affatto contraddittoria modalità che
Morone offre in parecchie sue composizioni con autenticità
leggermente spostata nella propria connessione. Ossia, il mondo
esteriore esiste, ma con un aspetto di ambivalenza: e citiamo i
grumi di colori-case e svirgolature espressioniste dei
Paesaggi, le grandi colate cromatiche dei Pleniluni
con i ritmi di fuori e quelli interni posti in sincronia.
Certo, il filo che collega i quadri all’arte raffigurativa è
solido, Morone -almeno oggi – non si pone ai veri confini, gli
preme piuttosto fornire un saggio di soggettività senza
ricorrere però alle facili allegorie; ma la realtà è di certo
separata dal realismo.
Rimane da esaminare il ciclo di
Fiori e archeologia che con quello delle Migrazioni
costituisce la più recente versione della pittura di Morone.
Ai fiori, come staccati dal
suolo, già siderali, rappresentanti la condizione dell’estremo
effimero, e proprio a commisurare la sostanza e la diversità del
tempo, si contrappongono nella parte inferiore del quadro
graffiti rupestri e runici, dolmen, anfore dissepolte,
conchiglie eccetera. In quel rapporto i fiori possono essere
considerati quali sismogrammi emotivi come certi calligrafismi
di Mathieu.
A prima vista, da simili quadri
si può dedurre, con un tale rapporto di misura e dismisura
temporale che l’eternità – l’hanno già detto altri – comincia e
finisce oggi. Oppure si dimostra che la
storia ha diversi punti di vista centrali. Con tutto ciò Morone
non manifesta il rischioso piacere di essere “antico”: in una
siffatta tematica è meglio lasciar cadere le intenzioni esterne
e lasciar carbonizzare i sentimenti. Che, infine, la storia la
si cominci a scrivere, o a dipingere, prima che questa esista
forse non è un temibile paradosso.
Vogliamo aggiungere che ad
alcune di queste composizioni non manca una suggestione
animistico - totemica, un’eco sincera d’antiche cose
raccontate con impegno, uno scavare o reperire, più che soggetti
di architettura, calde
tracce dell’uomo: una vera geologia. Si deve trattare di una
realtà passata che nutre la presente: una mappa sovente
crittografica in cui l’arcaico non disperde la sua lezione che importa più della sua
databilità. Ma la distanza fra quelle antiche strutture (e
scritture) e noi e certo più psicologica che cronologica; il
rapporto, alla fin fine, potrebbe anche rivelarsi a temporale,
salvo che Morone abbia con i graffiti, i dolmen, sottolineato
una talquale archeologia
del presente (di oggi), un viaggio sempre attuale in una cultura
dimenticata ma indispensabile. Ha evitato di esibirsi in
qualsiasi esotismo del
tempo, ovviando al riguardo anche ogni pseudo-filologia
ricostruttiva. Chissà che egli non abbia inteso invece accennare
ad una sua privata, personale preistoria. C’è da scommetterlo,
se tornerà su un simile motivo.
Vogliamo infine ricordare che le
punteggiature gremite e sinuose delle Migrazioni possono
assimilarsi a limatura colorata che si muove in campi magnetici
(i soliti cieli turchini, scuri d’ogni quadro).
Le incisioni meriterebbero un
più diffusa notizia. I fiori, non di consonanza rappresentativa
come quelli delle tele, sono bloccati, più corposi e
disegnati. E’ un fitto erbario con segni duri e sottili, con
valori bruni e
bianchi su supporti ritmici sempre variati; fiori, lo ripetiamo,
che non sono più come quelle sigle-stenografate d’alcuni suoi
quadri. Le morsure, le riprese risultano molte, a secchi tratti
nervosi, e la tensione costante n’è forse il maggior pregio;
processo ideativo ed esecutivo sono simultanei, si arriva alla
pura essenza del soggetto, all’esatta qualità della linea che
non è solo mezzo di memoria formale. Non mancano oggetti, fatti
a mano d’uomo, reperti immemoriali, come se Morone si fosse
piazzato all’origine di quelle cose.
Ernesto Caballo
Gli “Altri
Spazi” di Morone
C'è da
chiedersi se, qualche volta, Lionello Morone sia un pittore
crittografico, il che non significa astratto, informale .
Inoltre, ad ogni personale presenta una morfologia rinnovata:
prima con Pleniluni, poi con Fiori e Paesaggi,
Fiori e archeologia, Migrazioni e, adesso con
Altri Spazi, senza rinunciare al se stesso di sempre.
Per i fiori
quasi si direbbe che egli ne incorpori il polline nei quadri e
persino nelle lastre: un paradosso, il nostro. Ma definire, il
suo, un mondo floreale, sarebbe sfalsare il tutto. Le corolle,
rinserrate, punteggiate e gli steli flessibili costituiscono il
sogno di lui chiuso a chiave. Nei Pleniluni e in tutte le
altre sue "serie" pittoriche risulta implicato un senso
"diverso": di una natura che vuole competere con un'altra
natura, e ciò mediante una ricerca per analisi e, a quando a
quando, lenticolare.
Di originale
- l'abbiamo già scritto in una precedente occasione – è ”la
molteplice, niente affatto contraddittoria modalità che Morone
mostra in parecchie sue tele, con un'autenticità leggermente
scostata nelle proprie correlazioni”. Ossia: il mondo esiste, ma
con aspetti pluriversi e di ambivalenza; e citiamo i grumi di
colore-case, le svirgolature espressionistiche dei Paesaggi,
le grandi colate cromatiche dei Pleniluni. Lune che non
di rado paiono uscire da crateri, da vertici di monti
incendiati, simili, nel profilo, a duomi e fortezze turrite;
altra volta irradiano calma, pace, atmosferici interludi sulle
alture e lungo le valli.
In Fiori
e Archeologia egli commisura un presente immediato, senza
durata, con un evo antichissimo. La scala, l'arco del tempo ha
in Morone molte classificazioni, norme e ordine rappresentativi.
Ad impegnarlo sono le distanze, contrapposte ad altre distanze,
non valutabili a palmi di pittura. E le Migrazioni
risultano ancora le metafore di queste lontananze,
l'aspirazione a giungere a remote, opposte rive che forse non
sono più terrestri; si veda la densità, la smarginatura di molti
suoi cieli, in apparenza calmi. Insomma: lo spazio è grande
dentro e fuori di noi, e questi dipinti ne segnano fasi e poli
irreversibili.
C'è un
senso, proprio nelle migrazioni, non solo dell'alternanza delle
stagioni, ma del grande inarrestabile flusso dell'esistenza nei
suoi aspetti premonitori e, insieme, suggestivi; si sente il
fiato largo di un esodo per i cieli, reso più attraente dal
mistero. Dove si poseranno quegli stormi di un'estensione
davvero galattica?, è forse l'abbandono, senza scampo, seppure
in una cornice luminosa? Ci chiediamo se riprenderà domani quel
concerto di gioie, di canti, di colori; se se torneranno quelle
colonie di uccelli, sinuosamente e vivacemente, in sintesi,
punteggiate (a seconda dei quadri vengono usati tinte diverse).
Tutto sembra “scritto” nelle tele, negli incisi di Morone sotto
il dettato della speranza in nuovi incontri; ciò malgrado, ci
resta l'assillo dell'attesa.
Quel volo
che attraversa arie boreali, vapori tropicali, penetrando pure
la nostra vita, ci appare enigmatico, come enigmatica è la
rotta, verso chissà quali plaghe. Migrazione può essere
mutazione radicale nel mondo d'oggi sempre cangiante.
C'è pure una
tal quale festa della meraviglia, della tenerezza in questi alti
“passi” - che evoluiscono a folte cadenze-, ma accompagnata dal
rimpianto. Osservando quei nugoli alati, l'insicuro e il certo,
riguardo al ripetersi o meno dell'innocenza di tale gioco, fanno
contrasto dentro di noi.
Speriamo
significhi un condurre al largo, ad una spiaggia ospitale, anche
noi, uomini disorientati. Vorremmo conoscere le notizie che gli
stormi portano con sé, vorremmo anche noi approdare su un sogno.
Ma non sono i desideri che contano, bensì come vengono espressi
e raccontati: Morone ce ne ha dato la favola. Intanto ci
illudiamo di possedere le sequenze delle sue Migrazioni
con un solo sguardo.
E ora in
questa personale si aggiunge la serie inedita d Altri Spazi.
Come Eraclito era un “dirottatore di dogmi”, Morone è, a suo
modo, un dirottatore di idee-immagini. I suoi paesi, prima
radicati per colline e valli, si alzano con movenze aquilonari,
cercano e trovano un ambito che però non attenua la terrestrità
dei colori, delle impalcature struttive, anzi l'accentua. Vedi,
oppure intravedi, talora, panorami o, meglio, la loro ombra
riflessa negli sfondi e al basso, luoghi di sempre che forse non
sono più una nostra patria.
Paesi che
salpano, diventati imponderabili all'apparenza; la loro storia,
la loro coscienza si proietta sull'orizzonte. Una sorte, un
prodigio comune a molti, oggi che lo spazio ha gran parte nelle
misure umane, e guida, coinvolge noi stessi, le nostre remote e
recenti memorie. Sarà un presente diverso, un nuovo filo
conduttore che ci porta alle soglie di un “non finito”, e ci
ricorda il motivo delle Migrazioni dello stesso pittore,
ma che stavolta investe un maggiore agglomerato di colori, di
volumi: è la nostra condizione “sconosciuta” che aumenta
rispetto a quella “nota”.
In tale
senso Morone sceglie una sua logica esecutiva, permeata certo di
fantasia; lo zenith rimane ancora lontano, ma le cose e i fatti
parlano già la lingua della magia; conta però sempre il peso
corporeo, materico dei colori distribuiti abilmente, in sequenze
a volte translate. Se uno degli assunti primari della pittura è
l'invenzione, questo rappresenta un dato evidentemente
inventivo. Il mondo ha molti piani, come pure il suo cielo;
adesso Morone dipinge ciò che vede, o immagina, in alto. O sono
figure che non più la funzione del loro nome, con l'astrattivo
che acquista rilievo in questa traversata di pieni, di
rigurgiti, di vuoti d'aria, ma ancora con gli elementi
fisico-cromatici della realtà.
Chi ha
parlato di “viaggi immobili”?: forse questi lo sono, malgrado
l'abbrivio che sovente diventa urto ascensionale. Sono forme,
composizioni spesse, dai contorni movimentati di nebulose già
addensate, le quali hanno invertito la loro marcia, fuori di un
tempo cristallizzato che non sappiamo valutare, che forse non
esiste più. La vera via è altrove anche per queste meteore: è il
caso assoluto che dobbiamo accettare nei nostri giorni di grandi
e piccole relatività. Siamo al punto topico in cui tutti i
contrasti si conciliano.
Dopo anni di
assenza, al ritorno, anch'io vedevo il mio paese natale librarsi
sopra il bosco e la roccia, come in un'architettura disegnata
da Antonio Sant'Elia; ciò significa collocare le cose, malgrado
tutto, su un piano contemporaneo non solo mentale. Si può
discorrere tanto di geografie e astrografie gnomiche quanto di
una nozione di spazio che è assai meno innaturale di come
sembri.
Saranno
archetipi di un habitat che Morone ci presenta gravitante in un
cielo dove linee, figure si intersecano, si sovrappongono senza
perdere equilibrio in quelle masse filanti, stillanti talora di
arcobaleno.
“Per ogni
giorno c'è un paese nuovo per me”, è stato scritto; ed ecco il
pittore appagato: la sua Atlantide ora naviga alta su di noi.
Ci sono poi
le incisioni (acqueforti, acquetinte), sei delle quali raccolte
nella cartella Fiori Parlanti, contrappuntate dai ersi di
Marco Franceschetti. Con le sue percezioni, i suoi tempestivi
rimandi, il poeta si confronta in modo allusivo rispetto alle
immagini, senza cioè tenere, a buon diritto, un mero registro
testuale di convergenze, senza parallelismi, troppo analogici.
Nella
cartella, lo stesso scontro mimetico fra i due autori dimostra
però che essi si modellano mutuamente, ciascuno del proprio
stile; ed è uno dei pregi di Fiori Parlanti, forse con
qualche implicazione occulta.
I fiori,
morfologicamente inconsueti, embrionali, non si sottraggono
tuttavia ad una nomenclatura: valerianacee, diventate pappi
piumosi: (In un soffio / ti ricordo… scrive
entrando nel gioco Franceschetti); ci sono fasci di
papaveri: (E’ il papavero / che imporpora / il tuo
viso… così risponde l’eco del poeta). Sono “liriche” visive”
poste accanto, in una reciprocità effettiva, a liriche scritte.
Nelle lastre di Morone i soggetti hanno chiarezza, anche
sottigliezza d’impostazione; le prospettive, gli scorci,
appaiono sempre mobili, dentro temperie svarianti come in
Grano maturo con ventilabro. Il “fugato” di fiori continua
perfino su sfondi di graffiti e reperti, impronte rupestri: è
l’arcaico coniugato col presente effimero, dissociazioni “non
discordi” di cui si sente la pronuncia esatta nelle strofe,
tutte a flussi luminosi, di Marco Franceschetti.
Oltre la
cartella, continua l’attività incisoria di Morone nelle stampe
singole, a sé stanti, alcuni bicolori quali Cielo stellato,
due Migrazioni, un Plenilunio; altre in
rosso-arancio, seppia, marrone, oltre i bianco-grigi-neri. Sono
i temi della sua pittura, ma iterati liberamente; anzi alcuni
presentano marcati distacchi dalle tele, ad esempio Triciclo
abbandonato in un prato. Fra le lastre più riuscite ne
citiamo una che, in maniera meditata, ci ricorda il segno
elegante di Mathieu e lo sfrecciare serrato, davvero meteorico,
di Hartung: vi s’impagina appunto una meteora di Altri spazi
e una migrazione, in uno slancio timbrico sottolineato da una
specie di contro canto. La grafica, si sa, è la “spia di un
artista”; H. Focillon afferma che è “l’alterno diario della mano
umana”.
Si
apprezzano nei fogli una ritmica costante, fitta, le zone di
luce risolventi, il curveggio ora regolare, ora uncinante; i
vari rapporti del disegno assumono l’omogeneità voluta da Morone.
Trapela
dall’opera dell’incisore, un’intima rivelatrice del suo
carattere, cui fanno riscontro, e ne derivano, stati d’animo
evidenti.
Ernesto Caballo (1977)
Migrazioni e
Pleniluni
Sono stato
forse il primo “lettore” dei dipinti di Lionello Morone- ”mon
lecteur, mon frère” - gli ho suggerito di staccarsi dalla setta
privatissima degli iniziati, pur assecondando più di un ammicco
al metafisico e all'astratto. Pittore, fra l'altro, di paesaggi
allusivi, egli non vi chiude sopra i cieli; vive con una certa
irrequietudine la propria moderazione, affronta la pena
costitutiva dell'uomo che vuole creare una visione del suo
mondo; riesce ad equilibrare le polarità delle cose
rappresentate, sapendo che, oltre al colore e alla luce, conta
la posizione, cioè lo spazio che invade lo spirito. Eppoi ha una
gran modestia di fondo, non già di mezzi espressivi, e l'arte
per lui è qualcosa di più di una speranza, di una scommessa:
voglio dire che Morone non si cura dei “pedaggi terreni” (Apollinaire)
e d’altri onori proibiti, ad esempio la maestria, di cui
possiede ad ogni modo gli appigli; ma ogni uomo vive, respira in
un proprio stile.
Egli non
sceglie la neutralità, bensì il confronto. E' per il reale,
benché lo de-realizzi: lo ha dimostrato nella serie di Fiori
paesaggi, nei Fiori e archeologia, in Altri spazi e in una
cartella d’acqueforti tutte implicate nel seguire connotazioni
d’aspetti pluriversi e, al contempo di una schietta, articolata
equivalenza.
Oggi
presenta a Cuneo Migrazioni e Pleniluni, nell'alternanza delle
modalità pittoriche e grafiche. Nella prima serie si avverte non
solo il passo delle stagioni, ma il grande, inarrestabile flusso
dei loro aspetti premonitori, e si sente il fiato largo
dell'esodo attraverso i cieli, reso più suggestivo da un
mistero. Dove si poseranno questi stormi migranti, di
un'estensione e distanza davvero galattica? E' forse
l'abbandono, l'addio estremo, senza scampo, seppure in una
cornice luminosa? Ma noi crediamo in una via d'uscita che si
riaprirà dentro di noi. Si nota nei quadri, nelle acqueforti
delle Migrazioni una stimolante associazione dell'uomo con gli
impulsi e gli orientamenti naturali (non naturalistici). Tutto
s'incentra nel fiore dei nervi che emancipa il fitto repertorio
e le sue raffigurazioni dal gioco del caso e delle congetture.
Vale inoltre
la consistenza dell'immagine in se; se si prospettava un
labirinto fra la vita e l'uomo che la “dipinge, questo labirinto
non esiste più essendo stato superato. Si registrano infine
momenti di un paese alto e dolce, sebbene non manchi il gusto
dell'interrogazione, del dubbio: e questo per staccarsi dalla
vieta sentimentalità come dalla perizia tecnica fine a se
stessa.
Passando al
ciclo dei Pleniluni il discorso non cambia, con i ritmi, interni
e di fuori, posti in sincronia, con le grandi impennate
cromatiche di lune che paiono uscire qualche volta da crateri,
dai vertici di monti incendiati; in altre impaginazioni esse
irradiano calma, pace, interludi atmosferici sulle alture e
lungo le valli. Sono talora composizioni dai contorni
movimentati, come di nebulose già addensate: persiste comunque
un nesso logico in questi pleniluni espansi, e pure il fuoco
chimerico di alcune tele è governato, tuttavia, da uno schermo
filtrante, controllato. Coaguli, emulsioni, invenzioni di colori
risultano, in effetti, rese poetiche personali, in cui la
consonanza rappresentativa non viene compromessa: sono
fulminanti richiami di un’emozione naturale nell'ambito di una
tensione, sia in pittura sia in grafica. Qualcuno ha scritto:
"Far entrare l'ideale nel reale", e noi concordiamo appieno,
riguardo a Morone.
Concludiamo
dicendo che questa è creazione climaticamente e strutturalmente
felice. Il dipinto, il foglio inciso, questi luoghi fantastici
si legano nell'insieme in virtù dell'istantaneità della luce,
del segno. Si resta d'accordo, credo, che le opere di Morone
sono toccate con affetto dalla sua mano. E la sua arte
l'intendiamo “come vita innamorata di se stessa“.
Ernesto Caballo (1978)
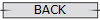
|