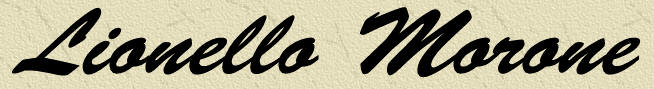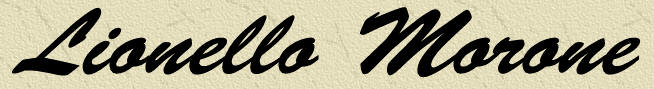|
Recensione
della Mostra a cura di Ernesto Caballo
Storia e
preistoria di un pittore
Che ci siano risultanze
allotropiche in non pochi quadri di Lionello Morone è fuori
discussione, così come è ammissibile che gli stessi titoli
globali, Fiori con paesaggi, Pleniluni,
Migrazioni intendano andare oltre la reperibile sostanza del
fatto figurale. Ma ci troviamo in un giro per niente vizioso fra
uno spogliarsi dalle maniere astratte, informali e da appigli
simbolisti e decorativi (certe tessere staccate di fiori fra
redoniani e klimtiani) per giungere a un paesaggio fisico, e
viceversa – ma di quanti pittori questo si può dire, da Gorky A
De Kooning, mettiamo, a Pignon, allo stesso De Stael: le
categorie della forma non contano in modo impegnato, esclusivo;
la scoperta di certi pittori d’oggi è la libertà anche in questo
senso ,giustamente è stato osservato che la materia tradizionale
pittorica va osservata come medium.
Dei fiori, sempre ricorrenti in
Morone, si può anche osservare che sono embrionali, puntuti,
duri; ma che egli intenda, per dirla con Cézanne, realizzare le
sue sensazioni alla presenza della natura è innegabile, e
giustifica così perfino in senso letterale i titoli delle sue
tele, così come gli elementi fedelmente morfologici nei profili
di astri, monti, valli no escludono la collusione informale,
raggiungendo talvolta una violenza cromatica, come in alcuna
Migrazioni, dell’intensità dei “Cobra”, timbrici, finanche
percussivi. A buon diritto A. Mistrangelo, dopo aver accennato
per alcune di queste opere a un simbolo magico di un nuovo
universo, accredita a quei colori un “senso di astrazione
contemplativa”.
L’interesse è la molteplice, niente affatto contraddittoria modalità che
Morone offre in parecchie sue composizioni con autenticità
leggermente spostata nella propria connessione. Ossia, il mondo
esteriore esiste, ma con un aspetto di ambivalenza: e citiamo i
grumi di colori-case e svirgolature espressioniste dei
Paesaggi, le grandi colate cromatiche dei Pleniluni
con i ritmi di fuori e quelli interni posti in sincronia.
Certo, il filo che collega i quadri all’arte raffigurativa è
solido, Morone -almeno oggi – non si pone ai veri confini, gli
preme piuttosto fornire un saggio di soggettività senza
ricorrere però alle facili allegorie; ma la realtà è di certo
separata dal realismo.
Rimane da esaminare il ciclo di
Fiori e archeologia che con quello delle Migrazioni
costituisce la più recente versione della pittura di Morone.
Ai fiori, come staccati dal
suolo, già siderali, rappresentanti la condizione dell’estremo
effimero, e proprio a commisurare la sostanza e la diversità del
tempo, si contrappongono nella parte inferiore del quadro
graffiti rupestri e runici, dolmen, anfore dissepolte,
conchiglie eccetera. In quel rapporto i fiori possono essere
considerati quali sismogrammi emotivi come certi calligrafismi
di Mathieu.
A prima vista, da simili quadri
si può dedurre, con un tale rapporto di misura e dismisura temporale
che l’eternità – l’hanno già detto altri – comincia e finisce
oggi. Oppure si dimostra che la
storia ha diversi punti di vista
centrali. Con tutto ciò Morone non manifesta il rischioso
piacere di essere “antico”: in una siffatta tematica è meglio
lasciar cadere le
intenzioni esterne e lasciar carbonizzare i sentimenti. Che,
infine, la storia la si cominci a scrivere, o a dipingere, prima
che questa esista forse non è un temibile paradosso.
Vogliamo aggiungere che ad
alcune di queste composizioni
non manca una suggestione animistico
- totemica, un’eco
sincera d’antiche cose raccontate con
impegno, uno scavare o reperire, più che soggetti di architettura,
calde tracce dell’uomo:
una vera geologia. Si deve trattare di una realtà passata che
nutre la presente: una
mappa sovente crittografica
in cui l’arcaico non disperde la sua lezione che importa più della sua
databilità. Ma la distanza fra quelle antiche strutture (e
scritture) e noi e certo più psicologica che cronologica; il rapporto, alla fin fine,
potrebbe anche rivelarsi a temporale, salvo che Morone abbia con i graffiti, i dolmen, sottolineato
una talquale archeologia
del presente (di oggi),
un viaggio sempre attuale in una cultura dimenticata ma
indispensabile. Ha evitato di esibirsi in qualsiasi esotismo del
tempo, ovviando al riguardo anche ogni pseudo-filologia
ricostruttiva. Chissà che egli non abbia inteso invece accennare
ad una sua privata, personale preistoria. C’è da scommetterlo,
se tornerà su un simile motivo.
Vogliamo infine ricordare che le
punteggiature gremite e sinuose delle
Migrazioni possono assimilarsi
a limatura colorata che si muove in campi
magnetici (i soliti cieli turchini, scuri d’ogni quadro).
Le incisioni
meriterebbero un più diffusa notizia. I fiori, non di consonanza
rappresentativa come quelli delle tele, sono bloccati, più
corposi e disegnati. E’ un fitto erbario con segni duri e
sottili, con valori bruni e bianchi su supporti ritmici sempre
variati; fiori, lo ripetiamo, che non sono più come quelle
sigle-stenografate d’alcuni suoi quadri. Le morsure, le riprese
risultano molte, a secchi tratti nervosi, e la tensione costante
n’è forse il maggior pregio; processo ideativo ed esecutivo sono
simultanei, si arriva alla pura essenza del soggetto, all’esatta
qualità della linea che non è solo mezzo di memoria formale. Non
mancano oggetti, fatti a mano d’uomo, reperti immemoriali, come
se Morone si fosse piazzato all’origine di quelle cose.
Ernesto Caballo
Recensione
pubblicata sul “Corriere di Torino e Provincia”
Agli ormai noti “Pleniluni” che
hanno caratterizzato buona parte delle sue composizioni,
Lionello Morone aggiunge ora “Fiori con paesaggi”, “Migrazioni”
e “Fiori con archeologia”. Il contesto generale è il medesimo:
colline e terre in continua tensione, tanto da immaginare
visioni di altri pianeti, i cieli scuri, strisce d’ombra di
fredda intensità, giochi di luce di misteriosa provenienza; poi
la presenza di un astro nell’infinito (non osiamo parlare di
luna o di sole) oppure fiori di fantasia che zampillano come
fuochi d’artificio. E se nei “Pleniluni” si potevano intuire
recondite dolcezze in questa natura primordiale, nelle
“Migrazioni” il colore diventa violenza ambigua, affascinante ma
certamente perturbante. Le insinuazioni di reperti archeologici
nei paesaggi sta a significare – con ogni probabilità – che il
mondo è finito, rimangono piccole vestigia a testimonianza del
tempo passato. In ogni sfumatura tematica, Lionello Morone
evidenzia la solitudine, un senso di panico coinvolge realtà e
ricordi, il segno dell’avventura è marchio materiale e
psicologico. Scrive Ernesto Caballo: “A prima vista, da simili
quadri, si può dedurre, con un tale rapporto di misura e
dismisura temporale, che l’eternità comincia e finisce oggi”. Ma
quale oggi? Le ere di Morone non sono classificabili, rimangono
sospese negli interrogativi più inquietanti ed il dramma
dell’umanità è già terminato, rimane una natura angosciata ad
attendere un nuovo ciclo, rimangono gli astri, i nuovi fiori, i
colori che vogliono vita. Si potrebbe parlare di pessimismo
eppure per una sorta di magico paradosso i dipinti di Morone –
dopo una certa assuefazione – portano serenità e pace, contro
ogni analisi logica.
Vittorio Bottino
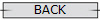
|